
Oggi parliamo con Paula Vexlir, psicologa clinica e fondatrice del sito web ExpatPsi, una piattaforma online di supporto psicologico e d’informazione per espatriati di lingua spagnola.
Cos’è ExpatPsi
Ciao Paula, grazie per aver accettato l’intervista. Potresti spiegare ai nostri lettori cos’è ExpatPsi e quali servizi offri?
Grazie a voi per avermi invitata. ExpatPsi nasce dopo molti anni trascorsi ad aiutare gli espatriati e i migranti. Sono una psicologa clinica e nel 2002 ho iniziato a specializzarmi in materia. Ho iniziato a notare problemi ricorrenti e, vista la mancanza di letteratura sull’argomento, ho iniziato anche una ricerca per valutare le differenze nella migrazione di persone differenti.
ExpatPsi ha tre aspetti importanti: i consulti di psicologia online, in modo che le persone che vivono fuori dal loro paese di origine possano accedere a uno spazio madrelingua con qualcuno che comprende bene la problematica specifica; un blog dove pubblico informazioni, strumenti, teorie, ecc. al fine di assistere nella prevenzione primaria; ed, infine, quest’anno ho iniziato anche a creare corsi e libri per aiutare più persone.
Immagino che affrontare la problematica “expat” dal punto psicologico debba essere molto interessante. In generale, potresti dirci che tipo di persone ti contattano e qual è il consulto più comune?
Sì, non solo è molto interessante, ma io sono anche fortunata ad avere un lavoro in cui posso verificare ogni giorno il mio apporto. In realtà i consulti sono molto vari: ci sono persone che sono espatriate per lavoro, cioè per richiesta dell’azienda, altri si sono spostati alla ricerca di nuove opportunità; ed inoltre ci sono studenti che vivono lontano dal loro paese d’origine.
A volte chi mi chiede un consulto è l’espatriato per richiesta dell’azienda e, altre volte, il suo partner. Forse può sorprenderti sapere che la maggior parte delle volte i consulti non sono specifici sulla migrazione. Voglio dire, sebbene queste persone stiano vivendo aspetti inerenti alla migrazione/espatrio, la maggior parte delle volte il consulto è su un altro tema. Qui è molto importante chiarire che comprendere la problematica “expat” è fondamentale quando si lavora con qualcuno che è espatriato, perché in caso contrario ci possono essere molti errori diagnostici o nell’ascolto.
Così, anche se il consulto può essere per una questione di coppia o lavorativa (o per la mancanza di un partner o di un lavoro), per fare due esempi, se si ascolta senza conoscere le specifiche dell’esperienza d’espatrio, ci sono molte possibilità di errori diagnostici o di valutazione di quanto si ascolta.
La psicologia dell’espatriato
Leggendo uno dei tuoi articoli in cui parli delle fasi dello shock culturale, sembra che non sia un tema del tutto risolto visto che le fasi ben definite della teoria (la “luna di miele”, lo shock culturale iniziale, l’adattamento iniziale, lo shock culturale reale e l’adattamento definitivo) non sempre avvengono. Personalmente, mi identifico di più con il grafico di Allison McCue, perché mentre vivevo in Cina ero capace di passare dall’amore all’odio più volte in uno stesso giorno. Pensi sul serio che ci sia un vero adattamento in quanto “expat”?
Sono pienamente d’accordo con la tua valutazione. Credo che le fasi, gli stadi per esempio dello shock culturale, del lutto o di qualsiasi altro processo, finiscano con il diffondersi per il bisogno insito in noi di sentire che possiamo controllare tutto. Non sono fasi nette. Per questo mi sembra così utile il grafico di Allison, perché più di una volta ho sentito persone preoccupate del fatto che il proprio stato non seguiva le fasi.
Una cosa è normalizzare le emozioni e i sentimenti e un’altra è fare un piano di come dovremmo sentirci. Penso che quello accada con il passare del tempo è che l’amore e l’odio diventano meno intensi, compaiono meno spesso nello stesso giorno e così a poco a poco si raggiunge l’adattamento. E’ anche vero che, anche se non ci fossimo trasferiti non avremmo gli stessi sentimenti per tutto il tempo e che alcune culture risultano molto più difficili di altre.
Nella mia esperienza “non professionale”, ho notato che tutti gli espatriati, presto o tardi, si bloccano in una fase di negazione in cui finiscono per odiare tutto ciò che riguarda il paese dove vivono. Questo atteggiamento è molto più frequente tra chi non padroneggia bene la lingua locale o proviene da una paese con una forte identità nazionale. Pensi che la mia analisi sia corretta? Secondo te, perché accade?
Allora, c’è un primo punto che è la decisione di imparare o meno la lingua locale. In questo caso è molto difficile generalizzare, perché esistono lingue che sono veramente molto complesse. Non dico che bisogna imparare la lingua locale per forza, ma sicuramente penso che si debba capire che se non si parla la lingua del posto, ci saranno differenze con chi la parla, e questo è inevitabile. Non tutte le culture sono ugualmente aperte agli stranieri e penso che comprendere le conseguenze delle nostre azioni sia sempre importante.
Inoltre non è la stessa cosa migrare verso una cultura che si ammira, invece di stare dove bisogna stare perché non si è trovato di meglio, ma che si considera “inferiore” alla propria cultura (suona orribile, lo so, ma molte persone si sentono così).
In generale, quello che dici, succedeva molto nelle “bolle expat” che si formavano nei paesi del terzo mondo. Non so se ha molto a che vedere tanto con l’identità nazionale forte, quanto con una posizione di conoscenza assoluta. Sarebbe come se nel loro paese di origine o nella loro cultura sono quelli che sanno davvero come dovrebbero essere fatte le cose, “non come questa gente qui che fa tutto sbagliato” (o strano, o qualsiasi altra cosa).
Vorrei chiarire anche che questa è una cosa molto umana, credere che ci sia un modo giusto, un solo modo. E a volte le distanze sono così grandi tra la cultura d’origine e quella che ospita che è molto difficile che non accada, ma di solito quando qualcuno ha questa – diciamo – posizione nella vita nei confronti del diverso, la noti anche in altri giudizi di valore su altri argomenti.
Una delle cose che mi ha sorpreso di più è stato lo shock culturale inverso, cioè quando ti risulta difficile adattarti al tuo paese dopo essere stato espatriato per tanto tempo. Secondo me, lo shock culturale inverso può essere molto più devastante di quello classico. Hai consigli per chi come me, nonostante sia a casa, non ci si senta?
Sono totalmente d’accordo con te, lo shock culturale inverso è spesso più devastante. Penso che in gran parte derivi dal fatto che non ce lo si aspetti. Si pensa che tutto sarà esattamente come lo avevamo lasciato, si pensa anche di essere come quando si era andati via, ma non è mai così. La prima cosa da dire è che non saremo più gli stessi, sarebbe impossibile il contrario. Così è come se “casa” non potesse essere più “casa” perché le manca qualcosa, no? Qualcosa dell’altra cultura.
A volte penso che dovrebbero avvisarti di ciò prima di lasciare il tuo paese, con un cartello in aeroporto con su scritto: “Se ti stai trasferendo in un altro paese per diversi anni, non sarai più lo stesso di ora, stai andando via e non ti sentirai mai più al 100% a casa quando tornerai.”
Il mondo globalizzato ci permette di accedere a questi prodotti “dell’altra parte” che ci mancano, tuttavia non riempie quel vuoto. Una parte della nostra identità rimane, nel migliore dei casi, nella cultura che ci ha accolto. Penso che questo sia un dono, se ben gestito, perché significa ampliare gli orizzonti. Perché adesso si può guardare la propria cultura e accorgersi di aspetti – generalmente contraddittori – che prima non si sarebbero potuti percepire.
Ma la verità è che adesso il proprio senso di appartenenza è cambiato e per questo mi piace dire che, dopo un’esperienza del genere, non si è più gli stessi, si vive come in un limbo, una sorta di non sono né di qui, né di là, no? O di sono un pò di ogni luogo.
Trasferirsi per amore
Immagino che molte delle persone che ti contattano abbiano deciso di lasciare tutto nel proprio paese per poter accompagnare il proprio compagno nella sua nuova destinazione lavorativa. Anche se queste persone hanno il tempo per potersi adattare più velocemente dei loro compagni alla nuova destinazione, in genere sono quelle che hanno più difficoltà e questo comporta delle ripercussioni nella relazione. A tuo avviso, qual è la cosa più importante per evitare che si arrivi a questa situazione?
In realtà sorprende vedere come chi mi chieda un consulto sia diviso al 50 e 50 tra gente che si è trasferita per lavoro e gente che ha accompagnato il proprio partner nella nuova destinazione per ragioni lavorative. Proprio come dici, anche se questi ultimi hanno più tempo per adattarsi, in genere hanno maggiori difficoltà. Un aspetto da considerare è che chi all’arrivo ha già un lavoro, ha tutto pianificato: dove passare la maggior parte della giornata, un gruppo di persone con le quali interagire ed una vita organizzata.
Mentre chi viaggia per altri motivi, per esempio per accompagnare il partner, deve “crearsi”, per così dire, la propria routine quotidiana. Deve trovare il modo di creare rapporti sociali e svolgere attività. Spesso è gente che nel proprio luogo di origine aveva un lavoro e non sempre è facile (e a volte per questioni legali è impossibile) trovare un lavoro simile. Questo va chiarito, perché la maggior parte delle persone che erano autonome nel proprio luogo di origine e hanno difficoltà nella nuova destinazione, si sentono in colpa con sé stesse per non riuscire ad adattarsi con successo, proprio perché hanno tanto tempo.
Oggigiorno si minimizza molto la difficile posizione di chi lascia tutto per accompagnare il proprio partner. Da fuori sembra che non abbiano di che lamentarsi, che abbiano una vita facile e tutti vorrebbero essere al loro posto. La realtà è invece molto diversa: oltre alle preoccupazioni, il senso di sradicamento e la perdita di identità che comporta l’espatrio, si aggiunge la pressione sociale di chi dice che dovrebbe andare tutto bene perché non bisogna andare a lavorare, quando, la maggior parte delle volte, quello che queste persone vorrebbero di più è poter lavorare e tornare a sentirsi a proprio agio con la propria vita quotidiana.
Un punto chiave è quello che mi piace chiamare “ritrovarsi”. Molte volte ci si riduce come un’appendice del partner e altrettante ci si sente asfissiati e impotenti. Se uno riesce a ritrovare se stesso, con i propri interessi, inquietudini, con quello che è importante per ciascuno nella vita, è allora che si può cominciare a trovare un modo per trarre il meglio possibile dall’esperienza internazionale.
A volte sono gli ideali, le aspettative o le sofferenze represse, che impediscono che si possa intraprendere questo cammino. Un’altra questione fondamentale è ricordarsi della propria libertà di scelta, che generalmente in questi casi si tende a dimenticare, sentendosi prigionieri di decisioni che hanno preso altri.
Uno degli effetti della globalizzazione è che ci sono sempre più coppie miste (cioè di paesi differenti): quando queste decidono di stabilirsi nel paese di uno dei due, credo che sia molto frequente che chi si trova nel suo paese provi ad iper-proteggere l’altra perché non affronti da sola i problemi che sorgono giorno per giorno. Credi che questo influenza l’adattamento del partner? Credi che questo possa generare conflitti?
Voler prendersi cura dei propri cari in un certo senso è inevitabile. La tua domanda mi sembra interessante perché è quello che può accadere anche con i figli. A volte per volersi prendere cura degli altri si impedisce che questi sviluppino la propria autonomia. Credo che la sfida più grande dello stabilirsi nel paese di origine di uno dei due è che chi si è trasferito non faccia il classico processo di ambientamento. Cioè uscire con gli amici del proprio partner e non trovare un proprio gruppo, cosa che farebbe se si fosse trasferito da solo.
Il problema più grande si pone quando sorge qualche crisi di coppia, cosa che d’altronde è inevitabile, dato che succede in ogni coppia, espatriata o no. Uno dei due sta con tutto il suo gruppo e l’altro si rende conto che non si è creato spazi o legami propri. Credo che questa sia la cosa più complicata perché, l’eccesso di attenzione può andare diminuendo una volta che uno vede l’altro adattarsi o sbrigarsela da solo, però se chi si è trasferito non cerca spazi propri, questo si ripercuote eccome nella relazione e tale livello di dipendenza genera molti conflitti.
Bambini espatriati e di terza cultura (TCK)
Penso che una delle maggiori preoccupazioni dei genitori prima di trasferirsi all’estero sia come dirlo ai propri figli. Alla fine molti finiscono per fare l’errore di dirglielo solo all’ultimo. Quali pensi che siano gli errori più comuni che commettono i genitori in queste situazioni?
E’ molto difficile sapere cosa fare quando si deve dire al proprio bambino che si andrà in un altro paese e si lascerà tutto. Inoltre ognuno ha i sui propri sentimenti contrastanti dunque è inevitabile commettere errori. In effetti, un errore comune è quello di dirlo all’ultimo minuto o, al contrario, dire a un bimbo di tre anni che tra un anno si trasferirà, quando a quell’età la nozione del tempo è molto difficile da assimilare.
Un’altra difficoltà comune tra i genitori è aiutarli a dire addio, a chiudere una fase. Ancora una volta, i genitori hanno i propri sentimenti contrastanti riguardo al trasferimento, quindi a volte pensano che evitare gli addii renda le cose meno dolorose. Ma questo non capita mai. Per iniziare bene, abbiamo bisogno di aver chiuso bene. E sì, è doloroso.
Un altro errore che a volte si commette è quello di non dare spazio al bambino di parlare di ciò che lo preoccupa o spaventa o gli fa male. Come genitori, è molto doloroso ascoltare questi discorsi perché, naturalmente, gli adulti prendono le decisioni e quando li ascoltano magari si sentono molto in colpa.
Quindi si affrettano a dire che tutto andrà bene, che non si deve preoccupare e non ascoltano quello che dice. Per non parlare dei casi in cui i bambini non parlano, per non disturbare i genitori e in fondo nascondono tutto ciò che provano. La verità è che se si hanno problemi ad ascoltarli, si dovrebbe chiedere aiuto; può essere un professionista, ma può anche essere un altro membro della famiglia che non ha problemi ad ascoltare senza la necessità di risolvere, ma di ascoltare attivamente ciò che hanno da dire, permettendogli di esprimersi.
Inoltre, come ho già detto prima, sto scrivendo alcune storie per aiutare i bambini ad elaborare quelle emozioni, senza doverne parlare molto con i genitori. Perché, quando trovano il protagonista della storia che vive quello che loro stessi stanno passando, i bambini riescono a normalizzare i sentimenti, le emozioni, ecc.
Infine, direi che, nella maggior parte dei casi, si dice ai bambini che il cambiamento è buono perché avranno un migliore livello economico o migliori condizioni, ma per loro questo non è affatto rilevante.
Spesso ho visto bambini che hanno vissuto la maggior parte della vita all’estero rinnegare la loro cultura di origine, nell’affanno di integrarsi dove vivono, fino al punto estremo di rifiutarsi di parlare la lingua dei genitori. Come pensi che si debbano comportare i genitori in questo caso? Credi che questa situazione, se non si gestisce, possa portare a problemi d’identità futuri?
Da genitori di TCK o Figli di Cultura Terza o con influenze internazionali – come preferiamo chiamarli – è fondamentale capire che i nostri figli non avranno la nostra stessa cultura. Cioè, i TCK hanno un pò della cultura dei loro genitori e un pò della cultura ospitante; vivono tra due culture, per spiegarlo in qualche modo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, credo che se hanno un atteggiamento di forte rinnegazione può essere dovuto all’insistenza dei genitori o a un rifiuto sociale da parte dei coetanei o dell’ambiente verso loro cultura d’origine.
Durante l’adolescenza, i gruppi possono pesare molto – lo abbiamo vissuto tutti – ma poi nell’età adulta si vanno prendendo le decisioni più liberamente. La realtà è che non appartengono neanche al 100% al paese ospitante. Allora quanta minore pressione esista verso un lato o un altro, tanta più libertà avranno i giovani di trovare il “loro” modo di integrare entrambe le culture.
La vita da TCK porta con sè una difficoltà identitaria, e questo è inevitabile. Non appartieni al 100% a nessuna delle due parti e le persone tendono ad avere bisogno di etichettare, classificare e, certo, non si sa mai cosa rispondere alla domanda: di dove sei? I figli di cultura terza, per dirla in breve, hanno le loro radici nelle relazioni, nei legami. Dunque quanto più i genitori sanno come aiutarli ad attraversare questo “tra” culture che li identifica, meno rifiuti e migliori integrazioni vedremo.
Quali pensi che saranno i vantaggi e gli svantaggi dei TCK nel futuro?
In un mondo tanto globalizzato direi che, se aiutati a elaborare i dolori e accompagnati realmente nei loro processi, essere TCK porta più vantaggi che svantaggi. Muoversi naturalmente tra culture, accettare e capire con naturalezza le differenze, essere in grado di adattarsi rapidamente a qualsiasi situazione, sapere come stringere legami facilmente sono alcuni dei vantaggi. Gli svantaggi hanno più a che fare con non avere avuto supporto durante questa esperienza, in particolare nel processare il dolore.
Possono essere persone a cui fanno molta paura gli impegni, soprattutto a lungo termine, con difficoltà a radicarsi in un luogo o progetto. Possono avere molta paura di provare perdite improvvise (ad esempio, che tutto quello che sono riusciti a conquistare scompaia improvvisamente). Possono nascondere dentro tanta angoscia ed essere molto superbi. Ancora una volta, questo si può in gran parte prevenire se si consente loro di esprimere il dolore ed elaborarlo. Tranne il fatto che di solito tendono a non sentirsi del tutto “a casa” in nessuna cultura.
Grazie mille per avere risposto alle domande e in bocca al lupo per il tuo progetto!
 Biografia di Paula Vexlir: psicologa clinica, appassionata di interculturalità. Dal 2002 è specializzata nell’aiutare gli espatriati e i migranti ad affrontare delle migrazioni migliori, ad attraversarle con figli, a risolvere i problemi di lavoro e di coppia, a lottare contro angoscia e ansia.
Biografia di Paula Vexlir: psicologa clinica, appassionata di interculturalità. Dal 2002 è specializzata nell’aiutare gli espatriati e i migranti ad affrontare delle migrazioni migliori, ad attraversarle con figli, a risolvere i problemi di lavoro e di coppia, a lottare contro angoscia e ansia.
Photo Credits: ![]() The Expat by The Preiser Project
The Expat by The Preiser Project
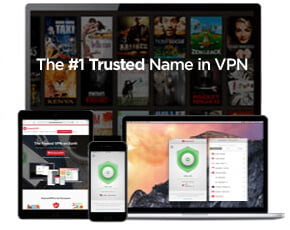
Ciao,
espongo il mio caso.
Siamo di ritorno a Parigi con la famiglia (la mia compagna e mio figlio di 8 anni), dove abbiamo già vissuto negli ultimi 5 anni. Dopo un breve periodo in Italia, ho accettato una proposta di lavoro di una’azienda francese e mi sono licenziato.
Mia moglie e mio figlio sono tutto sommato tranquilli.
Io che sono stato fautore di questa cosa, dopo una fase iniziale di euforia, vengo preso da mille paure come non essere all’altezza, lasciare i cari, vivere male il distacco dall amia attuale azienda nonostante una pessima situazione lavorativa.
Non riesco a capirne i motivi, ma poiché la cosa è, almeno per ora, difficilmente digeribile, sto andando da uno psicologo e sono un po’ depresso.
Avete avuto esperienze simili (mi auguro di no) o conoscete qualcuno che ha vissuto questa fase.
Saluti a tutti
Massimiliano
scusate ma questa frase:
A volte penso che dovrebbero avvisarti di ciò prima di lasciare il tuo paese, con un cartello in aeroporto con su scritto: “Se ti stai trasferendo in un altro paese per diversi anni, non sarai più lo stesso di ora, stai andando via e non ti sentirai mai più al 100% a casa quando tornerai.”
secondo me non ha molto senso se si parla di expat che non si inseriscono nella cultura del paese dove si sono trasferiti.
Ciao Marco,
secondo me dipende molto dal contesto. Onestamente io la pensavo esattamente come la psicologa, poi sono tornato in Europa e ho notato che, visto che non sono rimasto in Cina per decenni, piano piano sto dimenticando le mie abitudini “asiatiche”.
Anche se quando sono ubriaco / stanco / a 30 km da casa impreco sempre perché un taxi qui a Londra mi costa un occhio della testa
La psicologa farà pure il suo mestiere, io invece sono razzista: non capisco perché questa gente inutile, viziata, che si dimentica di essere ospite a casa d’altri, che non fa che lamentarsi, che tratta coloro che gli sta dando da lavorare con arroganza e sufficienza, a cui non va mai bene niente, a cui fa tutto schifo, che neanche prova a biascicare una parola della lingua, che non assaggia nulla, non faccia veramente un immenso favore all’umanità intera ma soprattutto a me rimanendosene a casa propria. Mi riferisco ovviamente a questi novelli “expat” (che poi perché si chiamano così? Perché non hanno il coraggio di chiamarsi con il loro vero nome, cioè “immigrati”?), petulanti e piagnucolanti pappemolli senza spina dorsale, senza curiosità, senza capacità di adattamento, senza capacità di esame di coscienza, di umiltà. E come staremmo bene noi diversi, noi (e sottolineo “noi” perché fortunatamente siamo anche tanti a non assomigliare per niente a quelli) che pur tra le mille difficoltà del vivere all’estero amiamo entrare fino al cuore del mondo nuovo che scopriamo giorno per giorno, senza doverci sorbire le paturnie e le lamentele di questa sottospecie di disadattati che farebbero bene a rimanere nella loro tanto amata “civiltà” con Maria De Filippi, David Letterman o Benny Hinn a prendersi cura dei loro guai. A me ed a quelli come me piace starei qui, in Cina, in Thailandia, nei paesi “strani”, e mi ci diverto pure. Non ci tengo a vivere da malato per morire da sano, una diarrea ogni tanto ci sta. Ed anche qualche fregatura, perché no, non si finisce mai di imparare. Sono di bocca buona, mi basta andare all’Ambasciata di Bangkok per rendermi conto della fortuna che ho a stare fuori dal mio Paese. Ma questi altri! Cosa li trattiene qui? Lo stipendio? Se fosse gente che vale dovunque troverebbe da fare, anche a casa propria. Che fosse che anche il loro Paese abbia qualche ragione particolare per lasciarli andare senza troppe remore? Gentaglia la cui ignoranza spiccia impedisce di riconoscere che è la diversità che arricchisce il mondo, nel bene e nel male, che sono gli aspetti più intimi e particolari di un paese straniero che vanno colti ed assaporati per avere esperienze gratificanti ma anche per, come diceva Pasolini, per il sommo piacere di essere scandalizzati. Imparando una lingua nuova anche se ostica ti aiuta poi a conoscere veramente bene la gente del posto, quella magari che non ha mai messo piede fuori dalla Cina o dal Congo o dalla Bolivia, quella che poi di fronte alla tua disponibilità ed alla tua curiosità è ben felice di accompagnarti dentro il suo mondo, con il suo cibo, il suo alcol, le sue donne ma anche con le sue tradizioni, le sue pazzie o – perché no – anche con la sua grande saggezza di cui chiunque al mondo appartenga coscienziosamente ad un mondo per quanto “strano” ti sa comunque trasmettere.
Poi certo, fa parte della tua libertà individuale accettare di fare parte di un certo mondo o di tirartene fuori; ma non è con questo comportamento vergognoso, ahimé tutto occidentale, che riuscirai veramente a guadagnarti il rispetto e la fiducia del prossimo.
Chi non sa vivere non merita nulla. Mi dispiace.
Ciao Jake,
condivido alcune delle cose che dici, però aggiungo che:
1. Se non lasci il tuo paese, non puoi crescere. Spesso gli “inadattati” di 10 anni fa sono gli expat che oggi si sono adattati a vivere nel paese di adozione.
2. La psicologia dell’espatriato è interessante perché, a mio parere, riguarda tutti: sia quelli che non si adattano che quelli che si adattano. Ti faccio un esempio pratico: un “break up” sentimentale dall’altra parte del mondo di solito è più difficile da accettare di un break up a casa tua, dove comunque hai il supporto della tua famiglia/amici. Stessa cosa per una malattia. E ciò è indipendente dal tuo livello di adattamento.
Ma infatti non ho nulla contro la psicologia di per sé. Dico solo che chi non ha capacità di adattamento deve rimanere a casa propria, certa gente non meriterebbe neppure l’attenzione degli psicologi…
Io penso che se uno è stato capace di costruirsi un giro di amicizie anche nel Paese d’adozione possa comunque trovare supporto in tutte le situazioni, anche quelle più difficili. L’adattamento secondo me c’entra in questo, perché il guadagnarsi la fiducia del prossimo in un altro Paese per quanto diverso ne fa parte.
Io condivido alcuni punti e meno altri.
Dici “comportamento tipico occidentale”, mentre io ti vorrei fare presente che quella descrizione potrebbe calzare benissimo anche a molti migranti in Italia. Non è una cosa “tipica occidentale”, ma tipica umana. Le persone sono diverse, le situazioni sono diverse e le reazioni sono diverse.
Ci sono situazioni in cui ti senti accettato, e come dici tu “è ben felice di accompagnarti dentro il suo mondo, con il suo cibo, il suo alcol, le sue donne ma anche con le sue tradizioni, le sue pazzie o – perché no – anche con la sua grande saggezza “, ma anche altre in cui è ben felice di lasciarti fuori, marginalizzato, escluso e sempre e comunque elemento estraneo, a volte pure esplicitamente. Può cambiare magari qualcosa da paese a paese, non so come sia in Thailandia, ma non credo sia radicalmente diversa dalla Cina.
@ Jake: c’è gente che non riesce a costruirsi un giro di amicizie nemmeno a casa sua. Penso che queste persone siano quelle che abbiano più bisogno di supporto psicologico.
@ Fabio: agreed
Ci sono dei tratti in comune ovviamente, ma la Thailandia mi sembra davvero un altro mondo rispetto alla Cina (dove ho vissuto tre anni).
Ovvio che poi gente che odia gli stranieri si trova ovunque. Il guaio è che per la maggior parte dei cinesi esiste la Cina ed il “fuori”; lo straniero è lo straniero indipendentemente dal fatto che sia italiano, americano, francese, russo, ecc…
Parliamo poi di un Paese che è rimasto chiuso ed isolato per secoli, quindi già diffidente in partenza. Logico che quelli con la puzza sotto il naso, arroganti e schizzinosi non hanno fatto che peggiorare la situazione, quindi non mi sorprendo che ci siano situazioni in cui si viene emarginati. Ma io sono sempre convinto che un atteggiamento diverso può cambiare – e di molto – le cose.
È come se avessi letto il mio pensiero. Vivo in Cina con il mio compagno e non perché siamo fighi ma semplicemente perché in Italia era un disoccupato.ma in Cina devo dire che ho conosciuto i peggiori italiani di tutta Italia. Pronti a sputare nel piatto dove mangiano.